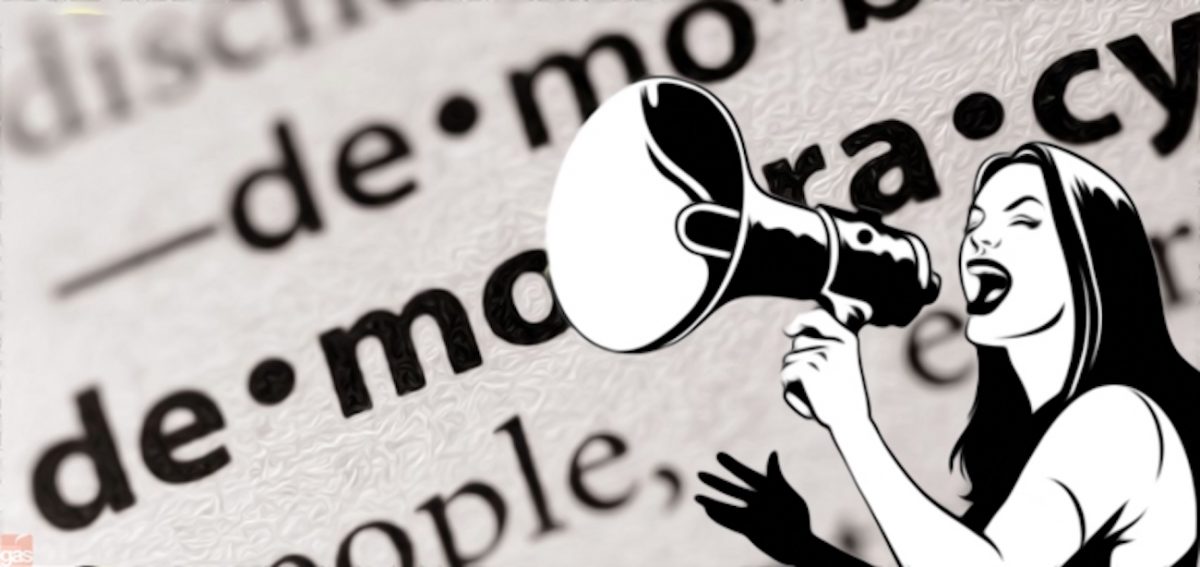Mia mamma quando aveva 20 anni lavorava e si è sposata. Quando è rimasta incinta, di comune accordo con mio padre, hanno deciso che lei poteva rimanere a casa, fare la casalinga e accudire i figli, mentre lui avrebbe lavorato, per due o per quattro se fosse stato necessario.
Entrambi si sono sacrificati per la famiglia: mia mamma per crescere mio fratello e me, rinunciando ad un po’ di sua indipendenza, mio padre lavorando anche la sera e i sabati, adorava il suo lavoro ma era anche un investimento per la famiglia.

Sacrifici, ma nessuno li ha mai vissuti come privazioni o come disuguaglianze sociali, anzi era il sogno di una vita che si realizzava: avere una casa, una famiglia.
Al giorno d’oggi no, tutto è disuguaglianza sociale quando non disparità di genere. Siccome la società è diventata più individualista, perché più veloce, allora marito e moglie DEVONO avere un’auto a testa, un cellulare a testa, magari vacanze divise, i propri spazi.
Allora a quel punto ci vuole anche uno stipendio a testa, su conti separati, ognuno con la sua carriera, la sua “dignità”.
Mi chiedo cosa ci sia di dignitoso e di equo in questa idea di famiglia che non è edificante come progetto comune, ma solo individuale.
Se ci si fa una famiglia per perseguire l’indipendenza ed equità individuale, allora tanto vale non intraprendere quella strada, ma anche questo è un fallimento sociale.

E se poi esce la statistica che nel 2020 le donne hanno perso il doppio dei posti di lavoro degli uomini il problema è la disparità di genere, non il valore del sacrificio per la famiglia.
Sacrificio che è di entrambi i generi: perché se è vero che la donna tipicamente è quella che più facilmente rinuncia al posto di lavoro per la famiglia, l’uomo è quello che ha la pressione di non doverlo perdere per la famiglia. Quindi NON È un problema di genere.
È un problema sociale: se anche dopo questo periodo pandemico non abbiamo capito che il famoso “cambio di paradigma” passa anche e soprattutto da questo, da un nuovo modo di intendere la società, perché nessuno si salva da solo, allora il problema è che non impariamo dalle esperienze.
Il problema non è che le donne hanno perso il doppio dei posti di lavoro degli uomini: quello è il risultato di una dinamica. Risolvere la questione dovrebbe partire da questo: non possiamo continuare a pensare che la famiglia sia un’accozzaglia di esperienze individuali.
Quindi può anche essere corretto che uno dei due genitori si dedichi alla famiglia, mentre l’altro alle risorse, ma nessuno deve perdere la propria dignità sociale che NON deve essere necessariamente riconosciuta nel posto di lavoro o dallo stipendio, ma “semplicemente” nel ruolo nella società.
Semmai quindi trovare delle misure sociali che garantiscano la dignità economica NONOSTANTE uno dei due genitori, ma anche entrambi alternandosi con una sorta di part-time (verticale o orizzontale), si occupi della casa e della famiglia, perché occuparsene non sia denigrante, vergognoso o poco dignitoso, anzi.
Io non reputo mia mamma sottomessa o discriminata perché ha fatto la casalinga tutta la vita e mio padre invece dominante o di successo perché si è spaccato la schiena lavorando: entrambi hanno fatto ciò che dovevano e desideravano per il loro progetto comune, con dignità ed orgoglio.
E questo deve tornare ad essere un valore per la società.
Questo è il cambio di paradigma, non tutte le volte cercare le differenze e voler rendere uguale tutto e tutti: una squadra, un team, un progetto, non arriva in fondo senza le necessarie, diverse, competenze e ruoli.
Facciamocela e facciamola finita con il fatto che OGNI cosa sia legata a disparità di genere. Ne va di tutti noi e meglio: del futuro della nostra società.

Passiamo da un’idea di dignità novecentesca basata esclusivamente sul lavoro, ad un idea che vada più verso il benessere della società: il COVID ha fatto risaltare anche questo, il bisogno di sviluppo sostenibile.